“Chi brama onor di sprone o di capello,
serva re, duca, cardinale o papa;
io no, che poco curo questo e quello.
In casa mia mi sa meglio una rapa,
ch’io cuoca, e cotta su ‘n stecco me inforco
e mondo, e spargo poi di aceto e sapa,
che all’altrui mensa tordo, starna o porco
selvaggio; e così sotto una vil coltre,
come di seta o d’oro, ben mi corco”.
(Ludovico Ariosto: “Satire” III – versi 40-48)
——————————————————————————————————
Conformismo è un termine inteso come adattamento agli usi prevalenti e ai desideri di chi detiene il potere. L’Enciclopedia Treccani lo definisce come la tendenza a “conformarsi, anche solo in apparenza, a dottrine, usi, opinioni prevalenti socialmente e politicamente”.
Se è così, cioè se si condividono solo comportamenti e indicazioni del gruppo di appartenenza e di chi dispone della facoltà di gestire il potere anche e soprattutto culturale, la questione più rilevante sarebbe il venir meno del senso critico e l’affermazione di censura e intimidazione, imposizione e divieti: tutto ciò inteso come controllo del pensiero.
È stato da poco pubblicato: “Il manifesto del libero pensiero” di Paola Mastrocola e Luca Ricolfi (La nave di Teseo/la Repubblica, 2021), un intenso e breve libro di grande attualità, soprattutto perché si sostiene che nella nostra società si è affermato un vero e proprio pensiero unico, una forma di dittatura, il politicamente corretto.
Sostengono gli autori: “al politicamente corretto dall’alto, gestito da aziende, istituzioni, piattaforme internet, si affianca una sorta di politicamente corretto dal basso, che agisce nei luoghi – reali e virtuali – della vita quotidiana”. (Ivi, 84)
Una trentina di anni fa al posto dei valori (uguaglianza, classe operaia, deboli) ha preso piede, in ambito progressista, l’essere “anti-qualcosa” (antirazzismo, antidiscriminazione): le lotte sociali sono state sostituite dalle lotte per i diritti civili. La conseguenza è il disprezzo dell’avversario. Ed allora chi è a favore di qualcosa è contro chi non lo è, ripercorrendo antinomie del tipo: “antirazzista / razzista, antidiscriminazione sessuale / omofobia”.
Paola Mastrocola e Luca Ricolfi rilevano che si è affermato un cambio di regime che impone una forma di linguaggio, che coinvolge arte, letteratura, cinema, che produce imposizioni e divieti su che cosa è bene dire e pensare. Si afferma una dittatura dell’espressione che porta a creare situazioni definite il “follemente corretto”, che costringe anche gli intellettuali ad adeguarsi al pensiero unico, pena l’essere discriminati e lasciati in un angolo. Chi non firma una petizione, chi non prende posizione pubblicamente, chi non aderisce ad una causa, chi fa una vignetta irriverente, chi non si omologa è disprezzato. Eppure dovrebbe esserci la libertà di espressione, il rispetto della diversità, delle opinioni differenti, di altri sentimenti e modi di vivere. Invece c’è la sopraffazione del più forte, o almeno di chi si sente più forte, chi aderisce a ciò che dice l’establishment. (Ivi, 96-98)
Faccio un esempio. Oggi è messo sotto accusa Giorgio Agamben, per le sue idee sui vaccini. Il filosofo della nuda vita e dell’homo sacer è accusato di essere il guru dei complottisti, dei no vax e dell’estrema destra, perché non in linea con le posizioni del suo ambito di riferimento. Donatella Di Cesare asserisce di essere interessata a salvare Agamben da Agamben, perché non può assecondare ragionamenti negazionisti. Sostiene: se ha scrutato a fondo la deriva autoritaria del neoliberismo ed ha smascherato “la pseudosinistra vincente ed annacquata”, oggi produce danni “difficilmente stimabili (…) a partire da un sovrappiù di discredito gettato sulla filosofia”. (D. Di Cesare, “Caro Agamben, ti scrivo”, L’Espresso del 19 dicembre 2021) Ovvero, questo lo aggiungo, favorevole ai vaccini ma aperto alle idee di chi la pensa diversamente, la tesi è: era molto meglio mantenere un approccio allineato, magari conformista, per non discreditare la sua figura.
C’è il terrore di non essere considerati sufficientemente progressisti e di non apparire i portabandiera della lotta per i diritti civili: questo, dicono gli autori, spinge soprattutto la sinistra ad assumere con grande ipocrisia ruoli e atteggiamenti di subalternità. Ci si allinea ad essere buoni e custodi del Bene (intellettuali e politici di sinistra, movimenti femministi e LGBT, rockstar e rapper multimilionari), contrapposti ai “cattivi”, ossia la gente di destra, i conservatori, i tradizionalisti, gli omofobi, se non addirittura i veri e propri “fascisti”.
Citando Walter Siti, nel volume si riporta: “gli autori di sinistra sembrano credere che siano le parole a generare i comportamenti: il contrario dell’idea marxiana che siano invece le condizioni materiali a generare le idee”. (Ivi, 16)
Dunque, invece di cambiare le cose, si cambiano le parole e si giunge al politicamente corretto, facendo nascere le parole giuste che ognuno deve usare, generando conformismo. Così accade la realizzazione del sillogismo: politicamente corretto = sinistra; establishment = politicamente corretto; sinistra = establishment. (Ivi, 23)
Il ragionamento è: può esserci un autore progressista che non condivide la tendenza comune? Può esserci qualcuno che si oppone al modo di fare dell’establishment e di ciò che la società vuole per la moltitudine?
Ricolfi già in altre circostanze ha ragionato su queste questioni, rilevando come la centralità sia oggi affidata al linguaggio. Si è passati dalle questioni sociali a quelle linguistiche; più che puntare sul sociale, sembrano importanti le mutazioni linguistiche, traducibili in: 1) Internet e social (offese pubbliche, frequentazioni social); 2) Misgendering (come chiamare qualcuno in base al genere, puntare a codici di scrittura corretti); 3) Cancel culture (arte e letteratura affrontata con i nostri canoni etici, cancellando il passato); 4) Discriminazione dei non allineati (non conformità alle idee dominanti); 5) Identity politics (non competenze, ma appartenenza a determinate categorie; instaurare l’uguaglianza attraverso discriminazioni). I termini hanno un campo semantico, con significati interpretati anche soggettivamente, ma che comunque si fondano nei rapporti sociali, nelle relazioni intersoggettive. Quindi le parole sono importanti perché indicano una visione del mondo e consolidano una visione del mondo, sono nello stesso tempo strutturate (effetto delle pratiche) e strutturanti (produttrici di pratiche). (L. Ricolfi, “Politicamente corretto, le cinque varianti delle parole”, la Repubblica del 1 novembre 2021)
In conclusione del volume “Il manifesto del libero pensiero”, gli autori con fare propositivo producono 26 punti, chiamati: “Manifesto dei Libero Parolisti”, che costituiscono alcune indicazioni per tirarsi fuori da questo opprimente clima. Si legge di non volere vivere sotto “una cappa”, perché “non ci piace che qualcuno si erga a custode del Bene”. Occorre poi favorire chi la pensa diversamente, attraverso la libertà del linguaggio e delle idee; privilegiare un’arte chi sia libertà di espressione; deplorare la sparizione dell’ironia; rispettare ogni essere umano; puntare soprattutto su educazione e istruzione; accettare il passato ed ogni forma di cultura. E ciò perché il linguaggio giusto si è trasformato in qualcosa di pericoloso per la convivenza democratica. (Ivi, 99-104)
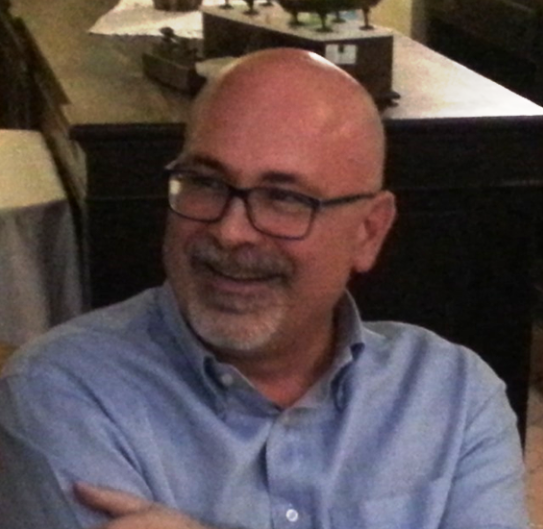

Certamente leggero questo Manifesto. Dalla mia esperienza personale e professionale ho maturato che Il pensiero libero è generato da un “sentire” libero da conflitti personali irrrisolti e dalla integrazione corpo psiche come ormai confermato anche dalle Neuroscienze. Il pensiero libero è così lontano da intellettualismi e da speculazioni filosofiche spesso inconsciamente narcisistiche.
Il sentire sul piano strettamente personale va inserito nell’ambito della complessità, che riguarda società, politica e quant’altro riguarda il rapporto uomo/ambiente. La posizione degli autori del volume è stata condivisa perché il pensiero unico sempre con più forza si afferma nel comune sentire.
Sono una persona che svolge un lavoro comune, e lo faccio orgoglioso delle mie radici operaie e contadine. Premetto questo per inquadrare l ambito da cui provengono le poche considerazioni che mi accingo a fare. Da sempre schierato a sinistra, non posso che condividere l idea che il linguaggio cosiddetto politicamente corretto sia una vera e propria sciagura. Se lo si introietta non si riesce più a farsi capire da coloro che si vorrebbe rappresentare, con buona pace delle migliori intenzioni. Se l ironia o al limite lo sberleffo, la voglia di vivere e di comunicare da pari a pari diventano “volgari” ecco che ce la stiamo cantando e ce la stiamo suonando da soli , ripetendo assunti formalmente ineccepibili e condivisi coi detentori del potere ed allontanando chi vorremmo (ma vorremmo davvero?) avvicinare. Mi viene in mente una conversazione, che Martucci ricorderà sicuramente, dove il professor Gembillo invitava gli astanti a distinguere fra complessità e complicazione. Ecco, nel politicamente corretto c è complicazione. Nel senso di una ridondanza di preoccupazioni che svuotano e sterilizzano la comunicazione. Non è davvero quel che servirebbe in questa fase, ma direi mai, in nessuna fase. Ma del resto questa è l era dei furbacchioni, dove il riformismo è diventato progressiva svendita delle conquiste sociali e via dicendo. C è via d uscita? Si, ritornare a soffrire, per ritornare a sentire, non a descrivere. È faticoso ma è possibile. Graziano Beghelli
Ringrazio Graziano per aver apportato il suo contributo